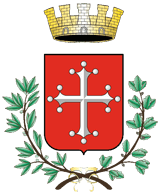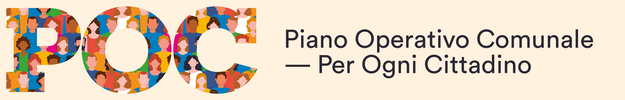| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIODIVERSITÀ [Fonte: Quadro Conoscitivo Comunale a corredo degli strumenti urbanistici - Comune di Pisa] L'ecosfera presenta una grande varietà di specie ciologiche, che viene chiamata biodiversità. La diversità biologica o biodiversità in ecologia è la varietà di organismi viventi, nelle loro diverse forme, e nei rispettivi ecosistemi. Il termine “biodiversità” deriva dal greco bios che significa vita, e dal latino diversitas che significa differenza o diversità. Come traduzione alternativa si potrebbe proporre biovarietà o varietà della vita presente sul pianeta. Il termine biodiversità, in effetti, è comprensivo di diversità, in numero ed in frequenza, di comunità, di specie, di patrimoni genetici della biosfera. Il termine biodiversità si è ormai consolidato e viene comunemente utilizzato nei diversi ambiti scientifici e culturali. Si considerano tre distinti livelli di biodiversità:
La biodiversità non è un valore fisso e stabile, ad esempio in un dato ambiente la biodiversità delle specie presenti può aumentare o diminuire nel tempo a causa di diversi fattori che possono essere di carattere naturale e/o antropico. Quadro di riferimento normativo Con la L.R.Toscana 56/2000 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche", è stata quindi data attuazione al D.P.R. 357/97 (e s.m.i.) e, conseguentemente, alle due direttive di riferimento ossia la Direttiva 79/409/CEE (e s.m.i.) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nota come direttiva “Uccelli” (abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), e la Direttiva 92/43/CEE (e s.m.i.), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (nota come direttiva “Habitat”). Ad oggi la L.R. 56/2000 risulta abrogata e sostituita dalla LR 19 marzo 2015 n. 30 “Norme per laconservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997 , alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”. CARATTERI GENERALI RIGUARDANTI IL S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) E Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale) ” SELVA PISANA” (IT5170002). Nel Comune di Pisa, la porzione interessata dal maggior grado di naturalità e biodiversità è individuata nel Parco Naturale di Migliarino-San Rossore Massaciuccoli, che occupa la sua parte occidentale e meridionale, con l’esclusione dell’abitato di Marina di Pisa, Tirrenia e in parte Calambrone, per più del 70% della estensione comunale complessiva. Il Parco, inteso come territorio ed ambito di competenza, è stato istituito con la Legge Regionale Toscana n. 61 del 13 dicembre 1979 che ne ha fissato gli scopi e delineato i confini. Il Parco si estende per oltre 23.000 ettari sul territorio di due province: Pisa e Lucca, e di cinque Comuni: Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Massarosa e Viareggio. È storicamente organizzato in “tenute”, ovvero in porzioni con peculiarità naturali, storiche ed architettoniche diverse le une dalle altre, ma collegate in modo vitale al resto dell’area protetta e quindi parte di un “sistema” organico e di una visione unitaria di più ampio spettro. Presenza di aree protette SIC-ZPS (IT5170002) = Sito interamente compreso nel Parco Regionale "Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli". Tipologia ambientale prevalente Sistema di dune e interdune fossili con alternanza di pinete a pino marittimo e pino domestico, macchia alta, aree umide e boschi igrofili. Coste sabbiose con ecosistemi dunali, canneti, cariceti e altre formazioni di elofite. Altre tipologie ambientali rilevanti Corsi d’acqua, vegetazione ripariale e formazioni erbacee perenni e annuali di alofite. Habitat Habitat d’interesse comunitario presenti nel SIC Selva Pisana
Componenti abiotiche Geomorfologia L’area del SIC “Selva Pisana” ricade all’interno di una vasta zona comprende un sistema di aree umide salmastre, costiere, oggi fortemente frammentato a causa degli intensi processi di urbanizzazione dell’area. L’attuale assetto geologico e stratigrafico degli strati superficiali di terreno dell’area è principalmente legato agli effetti della presenza di vaste aree paludose in rapporto alle variazioni eustatiche del livello marino e dei variabili equilibri della dinamica costiera. Si tratta quindi essenzialmente di depositi eolico transizionali dei lidi e dune litoranee. Si descrive, di seguito, la successione stratigrafica dei terreni affioranti. I terreni del comprensorio del litorale pisano hanno, com’è noto, una varia origine (in parte sono autoctoni e di origine marina ed in parte tipicamente alloctoni di origine fluviale) e presentano, quindi, differenti caratteristiche sia per la granulometria che per la composizione chimica e biologica. Di particolare interesse appare la prevalente consistenza sabiforme dei suoli di origine dunale, ricoperti da boschi di varia natura ed origine, dove fasce di maggiore altitudine (cotoni) si alternano ad aree più depresse ed umide (lame). Sono inoltre presenti i tipici argillosi dell’area prossima al fiume Arno. Componenti biotiche CARATTERISTICHE FLORISTICO-VEGETAZIONALI DEL SITO La pianura pisana, così come altre pianure alluvionali della Toscana, costituisce il luogo di raccolta e di smaltimento delle acque provenienti dalle zone collinari circostanti e del fiume Arno, acque che un tempo, per la difficoltà di deflusso, allagavano vaste aree di pianura soggette a impaludamento, creando le condizioni ecologiche per l’insediamento di un caratteristico mosaico di boschi igrofili, formazioni riparie, laghi e paludi permanenti o temporanee. Ancora oggi, nonostante il notevole condizionamento antropico, l’area è soggetta a fenomeni alluvionali, ma sono ormai quasi ovunque scomparse le caratteristiche formazioni vegetali di pianura. L’originario paesaggio vegetale è stato infatti trasformato, negli ultimi due secoli, da una intensa utilizzazione antropica iniziata con la bonifica di queste aree a fini agricoli (Pedreschi, 1951; Cori e Lombardi, 1994) e, più recentemente da una espansione dei centri abitati, delle aree industriali, delle sedi estrattive e dei sistemi viari. A tali interventi devono essere aggiunte alcune opere idrauliche (Canale Emissario del Padule di Bientina, Canale Scolmatore, ecc.) e numerosi interventi diretti sul corso del fiume Arno (rettificazioni, restringimenti dell’alveo presso i centri abitati, canalizzazioni e formazioni di tratti pensili sulla pianura circostante). Le formazioni ripariali oggi si presentano alterate sia in termini quantitativi che qualitativi con una riduzione dello spessore delle formazioni, ridotte ad una fascia di pochi metri (spesso a causa dello sviluppo delle attività agricole intensive) e con una riduzione della valenza ecologica soprattutto in considerazione della presenza di formazioni vegetali di sostituzione, costituite in parte da specie esotiche. Flora: caratteristiche generali Il SIC riguarda una selva costiera di grande importanza per i complessi forestali su dune e interdune umide, di notevole interesse ecologico, con vegetazione molto evoluta costituita rispettivamente da leccete e pinete con Pinus pinea e Pinus pinaster e ontani, querce-carpineti e alno-frassineti. L’area SIC in associazione alle aree contigue costituiscono ambienti ecologicamente diversificati in cui, ai fini vegetazionali, sono presenti tre unità fisionomiche fondamentali: Þ formazioni boschive ampiamente percorse da un reticolo idrico superficiale; Þ aree con carattere di prato-pascolo ovvero in attualità di coltivazione; Þ aree di spiaggia e duna che costituiscono il confine a mare del complesso.
Nel SIC “Selva Pisana” si possono riconoscere le seguenti principali comunità vegetali: Vegetazione psammofila delle dune costiere - lungo il litorale sabbioso si sono insediate comunità vegetali capaci di vivere in ambienti ad elevata concentrazione di salinità soprattutto nell’aerosol; si tratta in prevalenza di popolamenti psammofili ad Ammophila littoralis a cui si uniscono Eringium maritimum, Echinophora spinosa ed Euphorbia paralias; presenti aggruppamenti vegetali pionieri ad Euphorbia peplis e Cakile maritima e Helichrysum stoechas. Spartineto a Spartina versicolor – dense coperture prative a Spartina versicolor estese sino alle dune costiere; ad essa si uniscono in prevalenza Juncus sp.pl. e, in prossimità dei canali interni, Phragmites australis. L’aggruppamento vegetale è inquadrabile in Juncetalia maritimi Br. Bl. 1931. Vegetazione a Erianthus ravennae - nel settore nord-occidentale, dalle dune costiere verso l’entroterra, si ha un’ampia estensione di popolamenti densi a Erianthus ravennae inquadrabili dal punto di vista fitosociologico in Schoeno-Erianthetum Pignatti 1953. Giuncheti a Juncus acutus e giuncheti misti a Juncus sp.pl. - popolamenti densi a Juncus acutus e misti a Juncus acutus e Juncus maritimus a cui si uniscono Holoschoenus romanus e Bolboschoenus maritimus diffusi dalle dune costiere alle radure interne alla riserva; queste fitocenosi sono inquadrabili dal punto di vista fitosociologico in Juncetalia maritimi Br. Bl. 1931. Prati umidi e palustri dulciacquicoli - vegetazione dominata da prati umidi di pianura a prevalenza di Ranunculus repens, Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratense e Potentilla reptans. In corrispondenza delle frequenti bassure del substrato sono presenti popolamenti palustri a prevalenza di elofite con Phragmites australis, Carex otrubae, Carex distans, Cyperus longus, Juncus articulatus, Juncus inflexus e Eleocharis palustris inquadrabili nel Phragmitetalia Koch 1926 oltre a Iris pseudacorus, Sparganium erectum; a tratti una di queste specie può divenire dominante sulle altre. Nelle aree più interne soggette a sommersione stagionale s’insediano anche popolamenti a Erianthus ravennae e Schoenus nigricans. Vegetazione a Eleocharis palustris - popolamento a Eleocharis palustris che colonizza una piccola area depressa interna di San Rossore circondata dai boschi palustri a dominanza di Fraxinus oxycarpa. La fitocenosi è inquadrabile nell’associazione Eleocharicetum palustris Schennikov 1919. Magnocariceto - popolamento a grandi carici circondato da giuncheti alofili, boschi igrofili a dominanza di Fraxinus oxycarpa e pinete a Pinus pinea; a formarla un consorzio a Carex elata e Carex sp. a cui si uniscono Thelypteris palustris e tappeti a Hydrocotyle vulgaris. La fitocenosi è inquadrabile nel Magnocaricion Koch 1926. Formazioni a prevalenza Phragmites australis - formazioni a prevalenza di Phragmites australis presente con altezze medio basse e coperture non elevate; ad essa si uniscono, nelle bassure più salmastre, Juncus maritimus e Juncus acutus ed, in prossimità della foce dell’Arno, buona parte della flora erbacea che costituisce la formazione dei prati. Prati alofili a prevalenza di Salicornia patula e/o Limonium narbonense - aggruppamenti alofili a prevalenza di Salicornia patula si estendono in prevalenza ai margini degli specchi d’acqua prossimi alle dune costiere; sono presenti, praterie con Sarcocornia perennis, Limonium narbonense e/o Salicornia patula a cui si unisce spesso Hordeum maritimum. Le associazioni fitosociologiche sono riconducibili al Sarcocornietea fruticosae Br. Bl. Ex Tx. 1958. Boschi a dominanza di latifoglie igrofile - cenosi forestali di natura igrofila inquadrabili, complessivamente, nell’ordine del Populetalia albae Br. Bl. 1931. CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA DEL SITO Fauna: caratteristiche generali Le tre unità territoriali fondamentali sopra descritte (formazioni boschive, aree con carattere di prato-pascolo, aree di spiaggia e duna) costituiscono un ambiente ecologicamente aperto in cui le componenti faunistiche più vagili possono ampiamente dislocarsi sfruttandone, sia a livello stagionale che quotidiano, le potenzialità in termini soprattutto di risorse trofiche. MAMMIFERI I Mammiferi più direttamente legati alle aree boscate non rappresentano una cenosi particolarmente ricca, questa ha tuttavia aspetti peculiari venutisi a creare in conseguenza di una forte influenza antropica che da tempo opera sui luoghi. Tra i roditori, largamente presenti due specie arboricole quali il ghiro (Glis glis) e lo scoiattolo (Sciurus vulgaris), quest’ultimo comparso nell’area da non più di quaranta anni. Altro roditore presente il ratto alessandrino (Rattus rattus alexandrinus) specie tipicamente sinantropa, ma anche insediata con popolazioni prevalentemente arboricole ai margini boschivi. A livello del suolo troviamo comunità assai meno ricche di Micromammiferi quali il topo selvatico (Apodemus sylvaticus) e la crocidura minore (Crocidura suaveolens); queste popolazioni possono dare origine a considerevoli spostamenti di baricentro in conseguenza del succedersi stagionale delle fruttificazioni o delle variazioni che interessino la lettiera boschiva. Caratteristica anche la presenza del topo quercino (Elyomis quercinus) e del moscardino (Muscardinus avellanarius); la densità delle loro popolazioni non è mai rilevante e spesso esibiscono precise scelte di habitat, preferendo il sottobosco particolarmente fitto costituito anche da Erica scoparia. Di rilievo inoltre tra i roditori, la presenza dell’istrice (Hystrix cristata) anche se con insediamenti meno frequenti rispetto ad altre aree boscate, come conseguenza di una elevata pressione antropica. Di questa ultima non sembra soffrire il cinghiale (Sus scrofa) le cui tracce di presenza sono facilmente rilevabili in tutta l’area di studio. Tra i carnivori presenti nell’area, la volpe (Vulpes vulpes) è la specie più abbondante, ma sono ben rappresentate anche la donnola (Mustela nivalis) e la puzzola (Mustela putorius); rara è invece la faina (Martes foina). Il tasso (Meles meles) che in passato era solo sporadicamente presente oggi è ben rappresentato. Tutte queste specie sono largamente ritrovabili anche nelle aree di prato-pascolo e nei coltivi, dove l’attività umana richiama anche specie più strettamente sinantrope quali il topolino domestico (Mus musculus) e il surmolotto (Rattus norvegicus). Sempre tra i micromammiferi vanno poi citate forme insettivore di Crocidurini quali la crocidura maggiore (Crocidura leucodon) e minore, il mustiolo (Suncus etruscus), e tra i Microtini l’arvicola del Savi (Pitymys savii) particolarmente abbondanti in vicinanza dei coltivi. Le aree aperte sono ampiamente frequentate dal riccio (Erinaceus europaeus), mentre sono da confermare le assenze di insettivori quali i Talpidi (Talpa sp.) ed i Soricini (Sorex sp.). Egualmente non ritrovati nell’area di interesse i Lagomorfi altrove presenti, quali la lepre comune (Lepus capensis) e il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus). Infine, gli ambienti più strettamente acquatici oltre ad attirare popolazioni spesso dense di surmolotto, fanno registrare la presenza della arvicola acquatica (Arvicola sapidus anphibius) e della nutria (Myocastor coypus). Chirotteri Nella Tenuta di San Rossore sono state segnalate (AGNELLI ET AL., 2004) 13 specie di chirotteri: Rhinolophus ferrumequinum, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Myotis blythii / myotis, Myotis emarginatus, Myotis daubentonii, Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pygmaeus (prima segnalazione per il territorio toscano), Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Tadarida tenioti. Il dato è di estremo interesse sia per il preoccupante declino che interessa molte delle specie appartenenti all’ordine, sia per il numero rilevato in San Rossore, significativo se confrontato con il numero di specie segnalate in Italia dopo il 1980 (n° 32). L’attività di caccia delle specie interessa particolarmente gli habitat a bosco mesofilo a dominanza di farnia e frassino. Significativa anche la frequentazione nella Riserva Integrale del Palazzetto. Poco frequentati gli habitat “come il pioppeto, i coltivi, le pinete e l’alneto”. Tutte le specie rilevate in San Rossore sono riconosciute come specie di interesse comunitario ed incluse nell’Allegato IV della direttiva Habitat “specie che richiedono una protezione rigorosa”. Due di queste (Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii/myothis, Myotis emarginatus, sono incluse nell’Allegato II della direttiva Habitat “specie che richiedono la designazione di Zone speciali di conservazione”. La conservazione delle specie presenti in San Rossore è strettamente connessa al mantenimento e alla corretta gestione delle aree boscate ad elevata naturalità quali quelle presenti nell’area in esame. Mammalofauna Specie di particolare interesse conservazionistico appartenenti alla mammalofauna, considerato anche quanto espresso in Santini (1983), possono essere le seguenti:
UCCELLI L’importanza dal punto di vista ornitologico della “Selva Pisana” è nota da oltre un secolo. Questo sistema ambientale che si estende da Viareggio fino alla foce dello Scolmatore a Calambrone, rappresenta uno dei siti di maggior interesse per la Toscana sia per la presenza di uccelli acquatici che per la presenza di rare e localizzate specie terrestri, come si può evincere dalla consultazione dell’Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti della Toscana (Tellini Florenzano et al., 1997). Le lame presenti nella limitrofa Tenuta di San Rossore costituiscono un’area di interesse internazionale per la sosta e lo svernamento degli uccelli acquatici (sito ICBP; Serra et al., 1997). Anche la Tenuta di Tombolo costituisce una parte importante di questo sistema rappresentandone la prosecuzione verso meridione con una importante funzione di connettività con altri sistemi ecologici, oltre a costituire un elemento certamente fondamentale nel sistema di migrazione che interessa l’intero complesso. Nella “Selva Pisana” il ruolo ecologico svolto dagli uccelli è di primaria importanza; essi sono presenti con cenosi diversificate in relazione a fattori quali le variazioni delle associazioni vegetali che vi si incontrano e della loro complessità fisionomica ovvero dell’allagamento del suolo. La loro presenza è rilevante in ogni stagione dell’anno, con un continuo turn-over determinato dai movimenti migratori, erratici o dispersivi che caratterizzano questo gruppo dalla estrema mobilità. A livello di conoscenze scientifiche è doveroso ricordare l’opera dei tanti ornitologi che operarono in questi luoghi a cominciare dal Savi, attivo agli inizi dell’ottocento, o dal Caterini, di cui segnaliamo la preziosa “San Rossore e la sua avifauna” (1951). Oggi chi volesse interessarsi all’ornitofauna di questi luoghi non potrebbe prescindere ad esempio dai “database” del C.O.T. (Centro Ornitologico Toscano), un’istituzione scientifica che ha accumulato nel tempo migliaia di osservazioni. Ricordiamo inoltre la recentissima chek-list degli uccelli di San Rossore (Gambogi et al.,2005), che ha aggiornato le conoscenze per l’area boscata rivierasca segnalandovi l’osservazione di 291 specie rappresentative di 21 ordini e 63 famiglie differenti, o l’ancor valido lavoro di Meschini et al.(1991) sull’avifauna nidificante del Parco. RETTILI Nelle aree boscate sono presenti tutte le specie censite nel comprensorio del Parco. Va comunque sottolineato che in accordo con quanto segnalato da Mongini (1987) la presenza delle testuggini (Testudo hermanni e T. marginata) non è stata rilevata nemmeno negli habitat più xerofili e adatti per queste specie. Nelle aree più umide, nelle pozze, nelle lame e lungo i canali della zona di Tombolo, anche se difficile da scorgere è comune la testuggine palustre europea (Emis orbicularis). Comuni sono anche l’orbettino (Anguis fragilis) legato ad habitat diversi ma con unico comune denominatore l’elevato tasso di umidità e la luscengola comune (Chalcides chalcides) legata ai prati-pascoli, entrambi poco visibili perché assai elusivi date le abitudini fossorie. Il geco comune (Tarentola mauritanica) dalle abitudini notturne, trova rifugio di giorno nelle cortecce degli alberi e negli anfratti dei muri degli edifici. Sul terreno sono molto comuni il ramarro occidentale (Lacerta bilineata), la lucertola muraiola (Podarcis muralis) e la lucertola campestre (Podarcis sicula). Almeno sette specie di serpenti sono segnalate nell’area o comunque potenzialmente presenti: il biacco (Hierophis viridiflavus) che frequenta un’ampia gamma di ambienti e il saettone comune (Zamenis longissimus) legato agli ambienti ecotonali, la biscia o natrice dal collare (Natrix natrix) e la natrice tassellata (Natrix tassellata) entrambe legate all’ambiente acquatico. Difficilmente visibili perché di abitudini prevalentemente fossorie, ma tipicamente legati all’ambiente boschivo il colubro liscio (Coronella austriaca) e il colubro di Riccioli (Coronella girondica). Specie ben rappresentata nell’area a sud dell’Arno è poi la vipera comune (Vipera aspis). L’agricoltura intensiva, la crescente urbanizzazione e il traffico veicolare; interventi di derattizzazione e uccisioni dirette, alterazioni ambientali in particolare la distruzione della macchia mediterranea, sono le principali cause di minaccia per tutte queste specie. ANFIBI Le sponde dei fiumi e dei canali offrono un habitat abbastanza valido per accogliere gli Anfibi: la vegetazione ricca e l’umidità da essa trattenuta costituiscono un ambiente adatto per le rane verdi (Rana esculenta complex), e per la rana dalmatina (Rana dalmatina) prettamente terragnola, se non per la riproduzione. Le rane verdi non possono essere considerate specie in pericolo, c’è da dire però che le modificazioni ambientali prodotte dall’uomo negli ultimi decenni (bonifica di paludi e acquitrini, captazione di sorgenti, inquinamento dei corsi d’acqua) e le modificate tecniche agricole, stanno contribuendo alla progressiva rarefazione di questi anuri. I piccoli canali di irrigazione tra i campi o i canali collettori che attraversano la boscaglia sono frequentati da tritone punteggiato (Triturus vulgaris) e tritone crestato (Triturus carnifex). Tra i cespugli delle rive è comune la raganella italiana (Hyla intermedia), dalle abitudini arboricole. Sono poi presenti nell’area il rospo comune (Bufo bufo) e il rospo smeraldino (Bufo viridis). Nell’area è stata segnalata anche la presenza della rana appenninica (Rana italica), in particolare nei canali della Tenuta di Tombolo, pur essendo tipica di altri ambienti (Nota: era stata segnalata diversamente poiché fino a pochi anni fa era considerata sottospecie di R. graeca, specie attualmente riconosciuta come entità esclusiva della penisola Balcanica). La gran parte delle specie segnalate è adattata ad acque francamente dulcicole, di conseguenza la frequenza e l’entità delle popolazioni è strettamente legata alla salinità delle acque. Stante la forte penetrazione del cuneo salino tutte le specie citate con ciclo vitale legato all’acqua sono in declino numerico e in potenziale pericolo di estinzione locale. PESCI Il popolamento ittico è quello tipico delle zone estuariali in cui si riscontrano ampie variazioni di parametri ambientali quali la salinità, il pH, l’ossigeno disciolto, la temperatura; fattori di instabilità ecologica che tendono a selezionare cenosi prevalentemente costituite da specie euriece, altamente tolleranti le variabilità ambientali. Il fattore principale che condiziona la presenza di specie ittiche nelle aree di foce è la salinità, che varia in dipendenza di ritmi giornalieri di marea, delle condizioni meteo-marine, e stagionalmente in corrispondenza delle variazioni di portata del fiume stesso. I complessi movimenti delle masse d’acqua creano poi condizioni ecologiche differenti, con il cuneo salino di risalita che viene ad occupare la parte centrale e più profonda dell’alveo, per la maggiore densità delle sue acque, mentre superficialmente e sotto riva prevalgono, anche in condizioni di magra, le acque dolci in discesa. Tali condizioni consentono l’insediamento di un popolamento ittico eterogeneo, che può essere, in via schematica, suddiviso in tre contingenti: il primo comprende un gruppo di specie fluviali stenoaline caratteristiche dei bassi corsi fluviali (zona dei ciprinidi), più o meno snaturato da immissioni antiche e recenti che ne hanno profondamente alterato i rapporti zoocenotici. La consistenza dei popolamenti delle singole specie risulta spesso bassa, anche in considerazione della qualità delle acque. Vi ascriveremo l’alborella(Al burnus a. alborella), il cavedano(Leuciscus cephalus), la lasca (Chondrostoma genei), la scardola (Scardinius erythrophthalmus) ma anche il carassio (Carassius carassius) e la carpa (Cyprinus carpio) nonchè i sempre più rari barbo comune (Barbus plebejus) e tinca (Tinca tinca). Presenti anche la piccola gambusia (Gambusia holbrooki), il pesce gatto (Ameiurus melas), il persico sole (Lepomis gibbosus) ed il persico trota (Micropterus salmoides), tutti più o meno recentemente introdotti, con varie finalità, nelle nostre acque. Un secondo gruppo comprende specie eurialine tipiche degli ambienti di foce tirrenici, certamente più ricercate ed appetibili delle precedenti, ad iniziare dal branzino (Dicentrarchus labrax) e dall’orata (Sparus auratus) senza scordare l’anguilla (Anguilla anguilla) e soprattutto il loro stadio larvale: le tanto celebrate quanto introvabili ceche (o meglio cee, un nome che da Livorno a Viareggio evoca indimenticate immagini di tradizione culinaria). Interessanti anche piccole specie come il lattarino (Atherina boyeri), il pesce ago (Syngnathus abaster), il nono (Aphanius fasciatus) od il ghiozzetto marmorizzato (Pomatoschistus marmoratus), tipica specie bentonica. Dal mare ampiamente risalgono le varie specie di muggini (almeno cinque quelle segnalate da Gandolfi et al. (1979) mentre di notevole interesse ecologico e conservazionistico è la presenza della lampreda di fiume (Lampetra fluviatilis) e della cheppia (Alosa fallax); queste ultime sono specie migratrici potamotoche che penetrano nei fiumi a scopo riproduttivo. Quasi scomparse negli anni sessanta-settanta, hanno popolazioni oggi in ripresa; il loro ricomparire è senz’altro dovuto ad una migliorata qualità delle acque nel medio corso fluviale, dove si riproducono. Terzo contingente, infine quello delle specie stenoaline marine litoranee che occasionalmente entrano nella foce sfruttando il cuneo salino: sono sia piccole specie bentiche come le bavose (gen. Blennius) od il ghiozzo nero (Gobius niger), che vari sparidi e labridi oppure l’acciuga (Engraulis encrasicholus) e l’aguglia (Belone belone). Specie appartenente alla ittiofauna dell’area, di particolare interesse conservazionistico, essendo la sua presenza legata alla qualità delle acque, è la seguente:
Si tratta infatti di una specie diadroma che stagionalmente risale in acque dolci per riprodursi esibendo una precisa scelta di habitat. Necessita infatti (Zerunian, 2002) di acque francamente dolci in cui sia possibile la crescita di alghe verdi filamentose usate per la costruzione del nido da parte dei maschi. INVERTEBRATI Per quanto riguarda gli Invertebrati, a fronte di un popolamento estremamente ricco e ben descritto, il numero di specie di interesse comunitario presente in loco è decisamente esiguo con la necessità di precise riconferme ed accertamenti tassonomici. La Scuola Entomologica Pisana ha per quanto riguarda gli Insetti, ben delineato le situazioni generali esistenti (Santini, 1979; Santini,1997 a, b; Della Casa, 1995). In particolare i Coleotteri coprofili sembrano rappresentare per l’area uno dei contingenti più appariscenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo, con popolamenti ovviamente legati alla effettiva presenza di Mammiferi selvatici o domestici di cui sfruttare le deiezioni per lo sviluppo in particolare delle fasi larvali. Egualmente importanti alcuni elementi come i Micetofillidi per i particolari rapporti che hanno con le essenze fungine ed i peculiari aspetti comportamentali. Ancora una volta la presenza di acque seleziona popolazioni di specie idrofile ovvero di specie con stadi preimmaginali acquatici. Per questo contingente sono fondamentali i caratteri di oligoalinità dei corpi idrici trattandosi in ogni caso di specie stenoaline con una precisa richiesta in termini di qualità dell’habitat.
|
Customer Satisfaction
Ritieni il sito "Diversità biologica" utile e ben organizzato?
Esprimi un tuo parere, cliccando sulla faccina che meglio descrive il tuo giudizio!